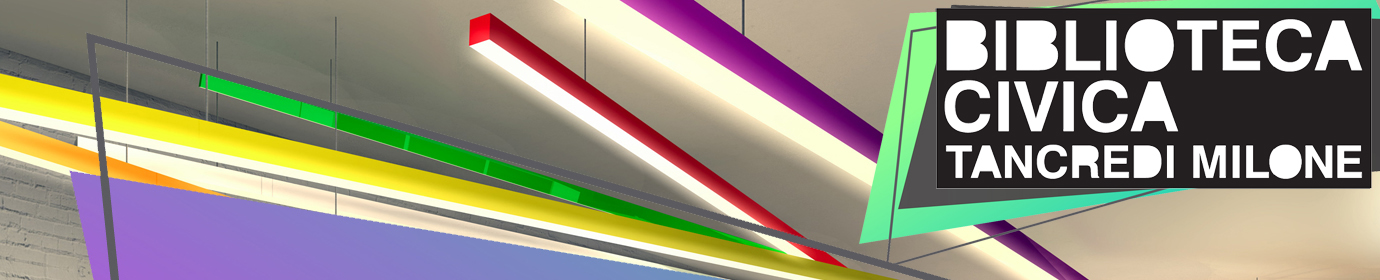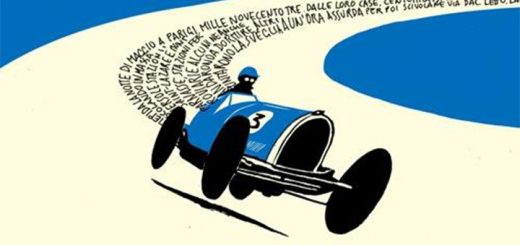Memoria e conoscenza

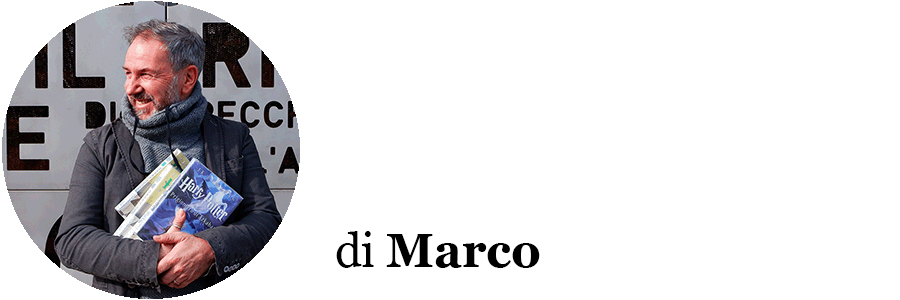
Nasce la Giornata della Memoria
Nell’ormai quasi lontano anno 2000, ci fu un passaggio importante da parte delle nostre Istituzioni: una legge dello Stato che istituiva anche per l’Italia il 27 gennaio, data della liberazione da parte dell’Armata Rossa del campo di Auschwitz, come il Giorno della Memoria.
Fu un passaggio importante per iniziare il processo di elaborazione della memoria, rappresentandone una vera e propria svolta. Tuttavia, sebbene a scuola, nei circoli culturali e politici se ne parlasse e affiorassero desideri di ricordare e raccontare attraverso la partecipazione attiva, molti vedevano un rischio nascere all’orizzonte: la routinizzazione e la burocratizzazione della Shoah.
La ritualità istituzionale
In effetti, a fronte del coinvolgimento (ormai da diversi anni) di istituzioni, cittadini e scuole di tutti i livelli alla realizzazione e alla fruizione delle iniziative legate al Giorno della memoria, anch’io mi sto rendendo sempre più conto di come questa ritualità stia diventando eccessivamente istituzionale, di quanto si stia esercitando sempre di più una sollecitazione estrema della memoria, quasi una sorta di bulimia che ci obbliga a “celebrare” , rischiando di farci perdere di vista il fatto che la Shoah, soprattutto di questi tempi, non sia più una “questione” dei soli ebrei, ma piuttosto un tema che ci riguarda tutti.
Costruire la memoria
La Shoah è diventata, con il passare del tempo, l’evento per eccellenza, una tragedia che ha traumatizzato il secolo scorso e alla quale non si può porre rimedio, almeno fino a quando l’umanità non vedrà consumarsi nuovi drammi e nuove disgrazie immani.
Il Giorno della Memoria, per tornare al suo significato più vero, dovrebbe probabilmente perdere quell’ufficialità che oggi lo avvolge facendolo apparire come puro evento celebrativo o paragone per altre tragedie. Le Istituzioni dovrebbero limitarsi a favorire una celebrazione non rituale, costruendo la memoria, qualunque memoria, con il sapere, attraverso lo studio e la conoscenza, coinvolgendo in primis bambinə e ragazzə: ciò per evitare di generare una grande stanchezza nell’opinione pubblica e, infine, il rifiuto alla partecipazione.
Ecco perché il nostro obiettivo è dunque quello di rivolgerci a lettorə più giovanə e più piccolə.
I crudeli giardini della vita
Un bambino degli anni Cinquanta passa l’infanzia a vergognarsi del padre, un modesto maestro elementare che il sabato, la domenica e talvolta anche durante le lezioni, si traveste da clown triste, senza far ridere nessuno. Più tardi, alle soglie dell’adolescenza, il ragazzo apprenderà con stupore che all’origine di quella mania c’è una storia avvenuta durante la Seconda guerra mondiale, quando suo padre e il cugino Gaston, 20 anni, avevano dovuto attraversare “i crudeli giardini” della vita, “devastati, insanguinati, spaventosi“. È la storia di un sabotaggio, di una probabile condanna a morte, di un soldato tedesco ricco di umanità e di umorismo, di una donna sconosciuta e disperata che ha un’idea capace di salvare due vite.
Le valigie di Auschwitz
Carlo, che adorava guardare i treni e decide di usarli come nascondiglio; Hannah, che da quando hanno portato via suo fratello passa le notti a contare le stelle; Émeline, che non vuole la stella gialla cucita sul cappotto; Dawid, in fuga dal ghetto di Varsavia con il suo violino. Le storie di quattro ragazzinə che, in un’Europa dilaniata dalle leggi razziali, vivono sulla loro pelle l’orrore della deportazione.
La guerra di Catherine
Rachel, giovane studentessa ebrea, frequenta una scuola speciale, la Maison di Sèvres, e ama guardare il mondo attraverso la sua Rolleiflex. Con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale è però costretta a fuggire e a cambiare identità. Aiutata da una rete di partigiani, Catherine – questo il suo nuovo nome – dovrà nascondersi in luoghi sempre diversi e imparare a fidarsi di persone nuove, senza mai separarsi dalla sua macchina fotografica. Da questo lungo viaggio prenderà vita la sua testimonianza per immagini che invita a non dimenticare la bellezza nascosta nel quotidiano e che celebra gli eroi anonimi, che mettono a rischio la propria vita per salvare quella degli altri. Un viaggio che l’aiuterà a crescere e che la trasformerà in una donna libera.
Il cavaliere delle stelle – La storia di Giorgio Perlasca
Giorgio è un bambino con un sogno: incontrare un cavaliere, capace di affrontare senza paura draghi e temporali, proprio come quelli che popolano le letture che ama tanto. Passano gli anni, Giorgio cresce, di cavalieri non ne ha mai incontrati. Parte allora per andare in guerra, sperando di conoscerne uno e compiere insieme grandi imprese. Scoprirà, invece, che l’unica avventura che valga la pena di vivere è l’amore. Ma proprio ora, il resto del mondo vuole la guerra. Un giorno arriva in una città lontana, dove alcune persone sono costrette a portare una stella gialla e altre danno loro la caccia. Lui non può accettarlo, vuole offrire il suo aiuto. Così va dall’Ambasciatore, che lo nomina cavaliere “protettore delle stelle”. Giorgio ha solo un’armatura di carta e una spada finta, eppure ogni giorno salva qualcuna delle persone con la stella e le nasconde in una torre. Finita la guerra tuttə potranno uscire dal loro nascondiglio, ma il cavaliere che li ha salvati è sparito. Passano gli anni, ormai Giorgio ha riposto la finta spada e non pensa più all’accaduto. Ma due delle persone che ha salvato non hanno smesso mai di cercarlo per dirgli grazie. Alla fine lo ritrovano, ormai anziano.
«Perché hai rischiato la tua vita per noi?»
«Perché l’amore è la più bella di tutte le avventure».