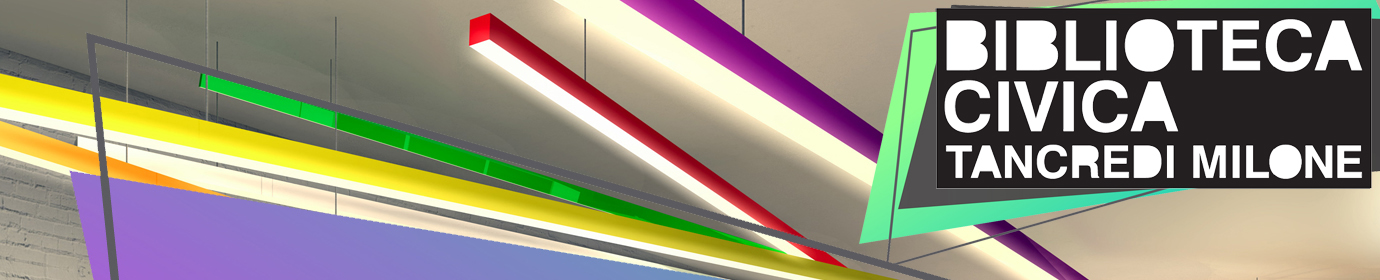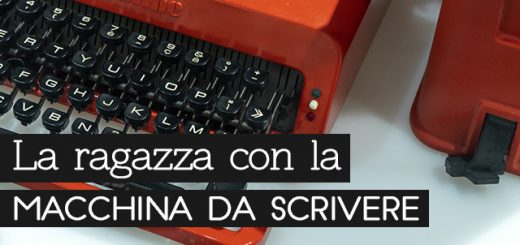Cinque domande con Enrico Pandiani

Il suo romanzo d’esordio, Les Italiens, è stato pubblicato nel 2009. C’è stato qualche motivo particolare per cui ha deciso di diventare uno scrittore?
Ho cominciato la mia carriera (se così la vogliamo chiamare) di narratore all’età di 13 o 14 anni, scrivendo e disegnando storie a fumetti. Per anni è stata la mia passione e il mio proposito di vita. Ne ho pubblicato parecchi su riviste come Il Mago, di Mondadori, o Orient Express, di Luigi Bernardi. A un certo punto, però, mi sono reso conto che non ero abbastanza bravo per diventare un vero fumettista, così ho piantato lì e mi sono messo a fare quello che alla fine è stato il mio lavoro per una quarantina d’anni, il grafico.
Ma ogni momento libero che avevo scrivevo, iniziavo romanzi che non finivo mai, uno dietro l’altro, senza alcuna velleità di pubblicare o di essere letto. Poi un giorno sono arrivati les italiens e ho terminato il loro romanzo, il primo che ho finito. In seguito Instar libri lo ha pubblicato e da lì è nato tutto; era il 2009. Il motivo per cui scrivo? Puro piacere, unito alla voglia di raccontare la mia visione del mondo e divertire i lettori.
I libri sono uno dei principali strumenti di diffusione della cultura: quanto ritiene che sia importante il mestiere dello scrittore in questo senso?
Il mestiere dello scrittore è importantissimo fin dall’alba dei tempi, altrimenti sapremmo molto meno riguardo chi ha abitato questa terra prima di noi. La scrittura, il romanzo in particolare, è un veicolo di conoscenza, di cultura, il modo migliore di sapere molto sugli altri, sui loro paesi e costumi, sulle loro vite, le speranze, gli amori, i dolori e le tragedie. Senza la lettura la mia vita sarebbe vuota, non esisterebbe neppure la scrittura. Credo che il compito di uno scrittore non sia quello di dare risposte, ma piuttosto di mettere i lettori di fronte a una serie di interrogativi che lo facciano pensare o lo costringano a prendere delle decisioni. Purtroppo in questo paese mancano i lettori, di scrittori ce n’è d’avanzo. È questo è un problema gravissimo, al quale non saprei dare una soluzione, né stabilire di chi sia la colpa. La scuola? L’editoria? Gli scrittori? Forse è un concorso di colpa.
I luoghi della cultura, come musei e biblioteche, sono stati particolarmente colpiti dall’emergenza sanitaria, qual è il suo pensiero in proposito?
I luoghi della cultura sono dei templi che tutti quanti dovremmo venerare, sono universi dove la conoscenza è alla portata di chiunque, dove la cultura viene assimilata per osmosi da chi li frequenta. E questo vale anche per le biblioteche, per la musica, per il cinema, per l’arte e per la scienza. L’emergenza sanitaria ce li ha tolti ed è stata una mancanza immensa, perché le città si sono svuotate, il turismo si è spento e tutto è venuto a mancare. Come un effetto domino, la chiusura di questi luoghi ha avuto una ricaduta pesantissima sulle nostre vite, sul sociale, sull’economia. Dopo gli effetti sulla scuola, questo è stato il disastro più ingente provocato da questa pandemia.

Il suo ultimo romanzo, “Lontano da casa”, ha un titolo particolare, sicuramente legato alla delicata tematica dell’immigrazione, ma quanto invece della sua casa, Torino, c’è in questo romanzo?
Io credo che le due cose siano legate strettamente fra loro. Questa casa non è soltanto mia, è di tutte le persone che la abitano, italiani o stranieri, di tutti quelli che da Torino si aspettano una vita migliore o più decente. Questo ci unisce, fa di noi un unico organismo che deve riuscire a convivere nonostante le difficoltà e i problemi. Ciascuno di noi che ha la fortuna di possedere una casa, un lavoro o una vita dignitosa, dovrebbe fare qualcosa per chi non ha questa fortuna. Altrimenti ci troveremo tutti lontano da casa, come lo sono i personaggi del mio romanzo. La lontananza, a volte, può essere una metafora dell’allontanamento, e l’allontanamento crea muri o baratri e non produce nulla di buono.
Grazie ai suoi romanzi viene accostato ai grandi autori del noir, fin da subito. Saprebbe svelarci un motivo del perché ha scelto proprio questo genere per i suoi capolavori? Quale romanzo consiglierebbe a un neofita interessato al genere?
È una domanda alla quale non so rispondere. È stata una scelta naturale, è arrivata da sola. Forse perché ho sempre letto molti romanzi di genere è ho una grande passione per quel tipo di storie. E questo benché io abbia letto molto più letteratura altra, che è quella che mi affascina e mi insegna la maggior parte di quel poco che ho imparato. Ma il genere è molto coinvolgente, anche per chi scrive, credo. Ed è un buon sistema per raccontare la nostra società e i contrasti forti che la animano.
A volte mi chiedo come potrei parlare della mia visione del mondo se non attraverso questo tipo di romanzi. Mi ci trovo bene e mi permettono di esplorare e sperimentare. Ho sempre pensato che il mio compito sia quello di cercare di spostare l’asticella del noir verso la letteratura altra, quella “nobile”, secondo molti. Diversi autori ci sono riusciti, io non ancora.
Penso che chi intenda avvicinarsi a questo tipo di scrittura dovrebbe leggere classici come Raimond Chandler o Hammet, Simenon, Manchette e Japrisot, i primi romanzi della Vargas o ancora Elmore Leonard, che è stato un maestro assoluto della tensione. Ma ce ne sono mille altri, Giampaolo Simi, per esempio, o Grazia Verasani, se vogliamo parlare di contemporaneo italiano.