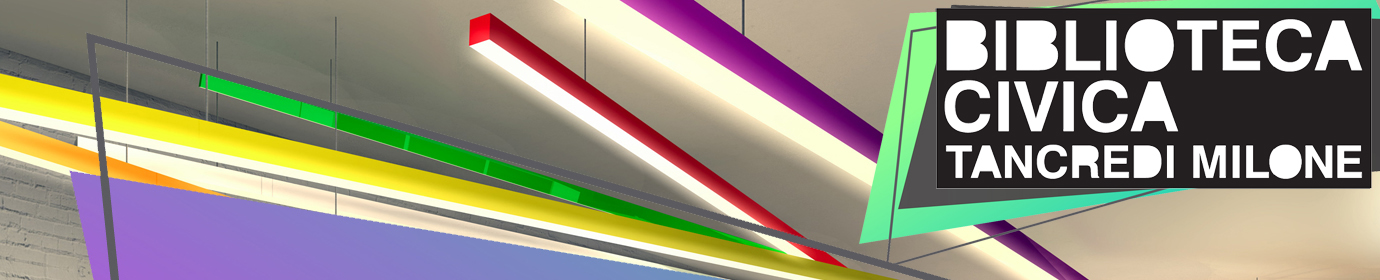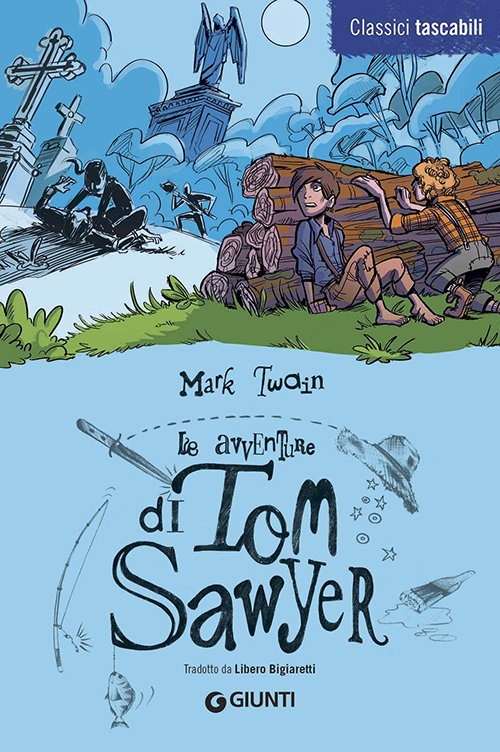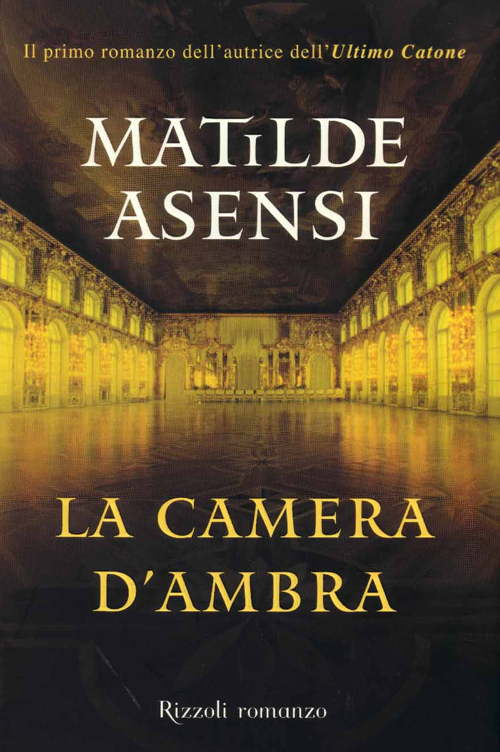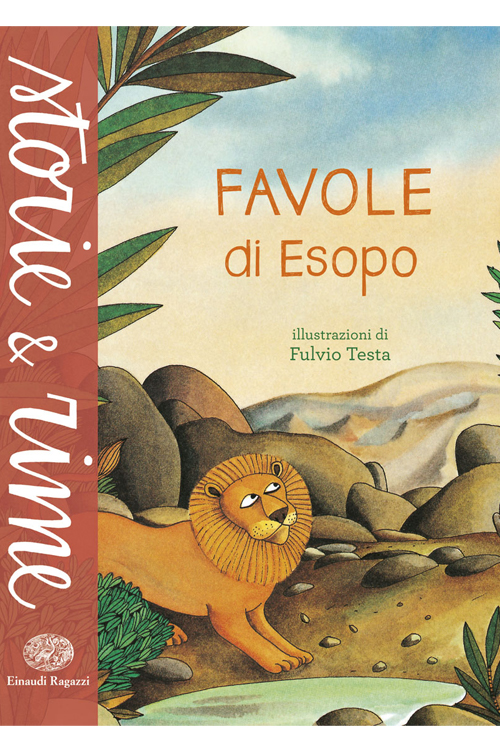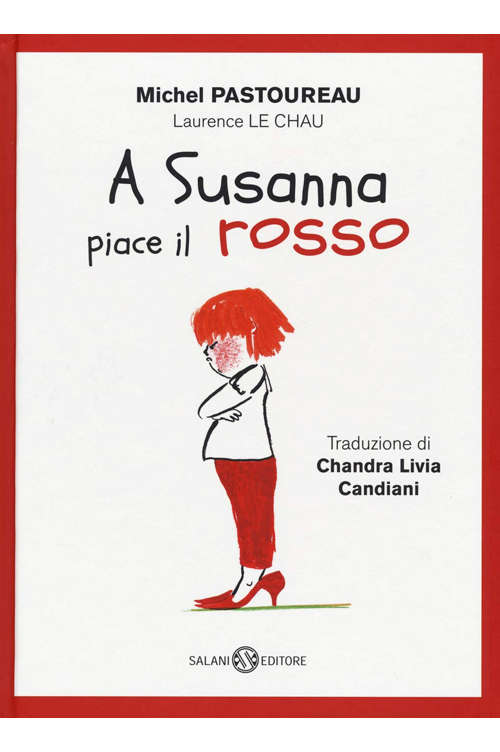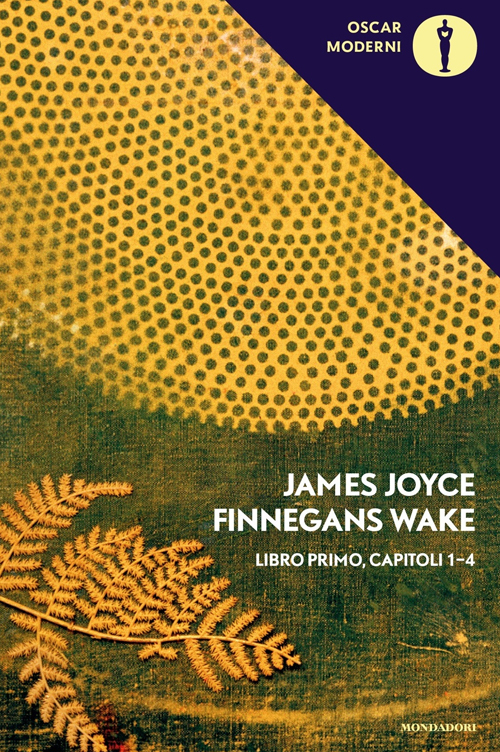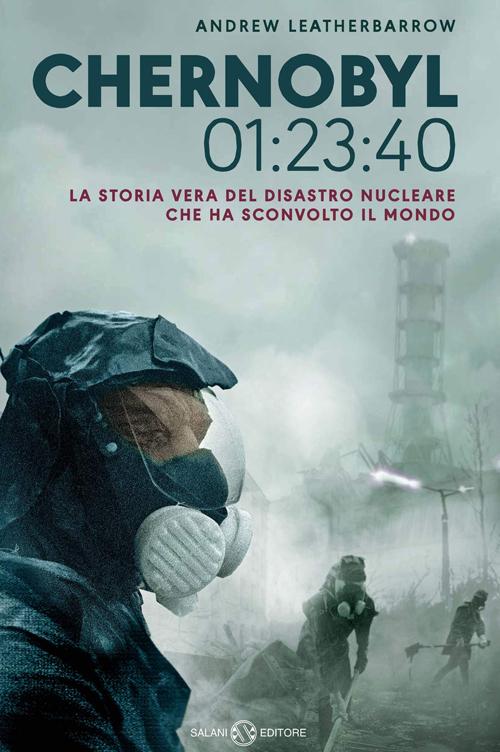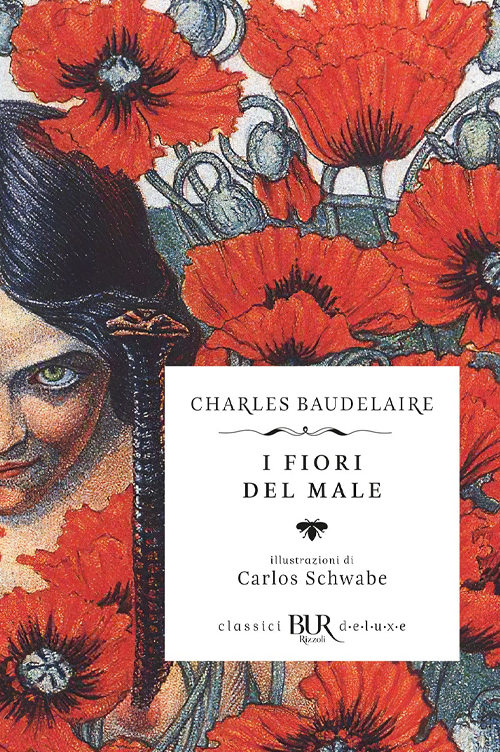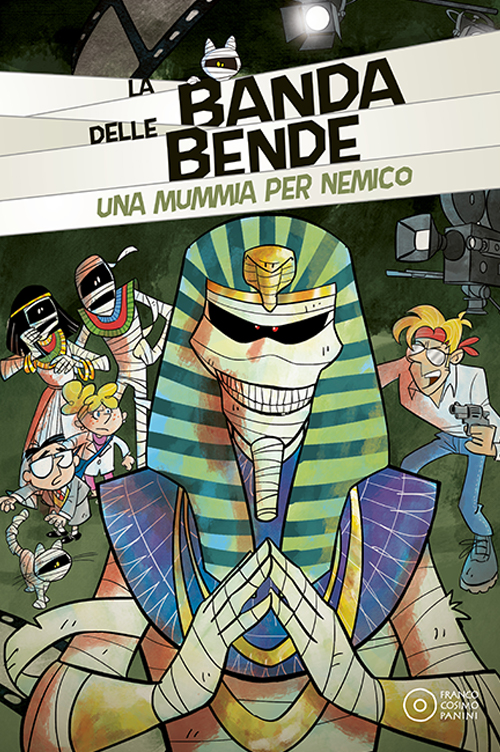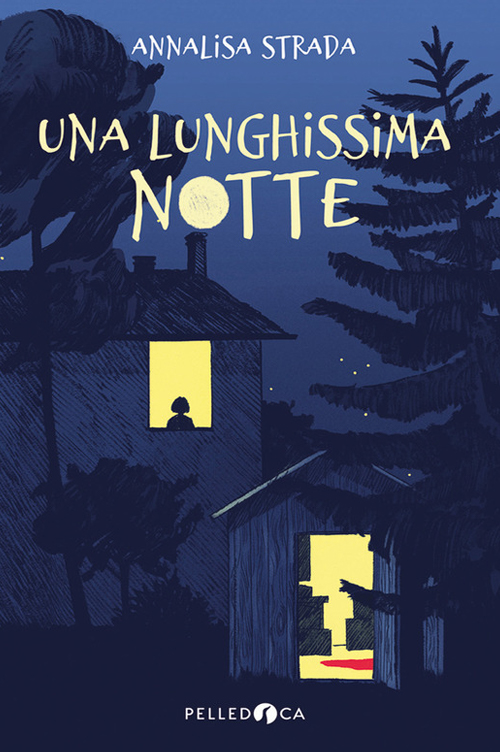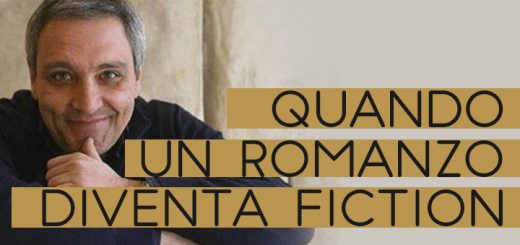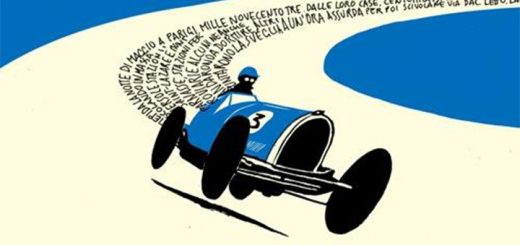Atlante sentimentale di libri e colori

Sfumature nel tempo
Siamo abituati a pensare ai colori come a entità astratte, eteree e immutate, codificate una volta per tutte in manuali e campionari ma non è affatto così: ogni colore ha la sua storia, il suo passato e le curiosità che risiedono in esso. Non solo: per ogni colore ci sono centinaia di tonalità, ognuna con caratteristiche e origini precise. E se ogni sfumatura ha la sua storia, possiamo dire con certezza che ognuna di esse ha cambiato anche la nostra di storia.
Bianco, tra macchie e pulito
Il bianco, come il leviatano albino di Melville, ha un’alterità tutta sua. Nell’immaginario collettivo infatti è sempre stato associato al denaro e al potere. Inoltre, nonostante faccia risaltare subito le macchie, è il colore del pulito. Una delle sue principali sfumature è il calce, la pittura più economica che esista e che ritroviamo in “Le avventure di Tom Sawyer” in cui il protagonista deve dipingere, come punizione, uno steccato con un secchio di pittura a calce: questo ci lascia intuire qualcosa sulla considerazione che avessero un tempo di questo colore.
Giallo, come i girasoli di Van Gogh
Il giallo è un colore dalla natura particolare: quando si manifesta nelle persone fa pensare a una malattia ma allo stesso tempo, nel mondo occidentale, era il colore del benessere economico e della bellezza. Nell’estate del 1888 Vincent Van Gogh scoprì il colore perfetto: il giallo cromo, derivato da un cristallo delle miniere di Beresof, in Siberia. Se vi foste mai chiesti di che colore fossero i girasoli di Van Gogh dunque, ora lo sapete.
Arancione pericoloso
Passiamo ora all’arancione, colore con una grande personalità: viene usato infatti per attirare l’attenzione su una particolare situazione di pericolo. Tuttavia fino al periodo impressionista non venne considerato un colore a se stante e per questo motivo corse sempre il rischio di essere confuso con altri colori come giallo, rosso o marrone. La sfumatura che ci ha colpito di più è l’ambra. Nel 1701 diventa la protagonista della cosiddetta Camera d’ambra appunto, una stanza le cui pareti erano composte da una serie di pannelli incisi in maniera intricata e da mosaici fatti di scintillante ambra color miele, all’interno del Castello di Charlottenburg a Berlino. Di questa curiosa storia parla il romanzo “Camera d’ambra” di Matilde Asensi.
Il rosa della rosa
In tutte le lingue romanze il termine ”rosa” deriva dal nome e dal colore del fiore omonimo. Il rosa, tuttavia, è molto di più del colore dei fiori: è infatti considerato il simbolo dell’amore. L’amaranto è la sfumatura protagonista della favola di Esopo “La rosa e l’amaranto“: la pianta di amaranto confessa alla rosa, sua vicina, di essere invidiosa della sua bellezza e del suo profumo. La rosa però risponde con tristezza: “O amaranto, io non vivo che pochi giorni, e anche se nessuno mi recide appassisco; ma tu fiorisci e vivi sempre così in perenne giovinezza”. Il tempo però ha dato torto ad Esopo: la bellezza della rosa è rimasta intatta agli occhi dei suoi ammiratori mentre il destino dell’amaranto è appassito.
Rosso rovente
Arriviamo così al colore rosso che ha da sempre uno strano effetto sulla psiche umana e non solo, secondo alcuni studi infatti sappiamo che: le cameriere vestite di rosso ricevono il 26% di mance in più, ai Giochi Olimpici di Atene del 2004 gli atleti negli sport da combattimento che indossavano una tuta rossa vincevano il 55% delle volte, mentre le squadre di calcio inglesi con divise rosse hanno più chance di imporsi sulle altre. Sfumatura particolare è il vermiglione: un tempo infatti era costoso e prezioso come l’oro, trionfava tra i rossi degli artisti medievali e veniva utilizzato con riverenza accanto alla foglia d’oro e al blu oltremare per le maiuscole nei manoscritti e nei pannelli dipinti a tempera. Vasilij Kandinskij lo descrisse come “un rosso con una sensazione acuta, come acciaio rovente che può essere rinfrescato dall’acqua“.
Il viola di Perkins
ll viola è un colore con uno status speciale un po’ in tutte le culture. Come molte cose speciali questo colore, per essere prodotto, ha sempre assorbito una quantità esorbitante di risorse: migliaia di crostacei infatti sono stati sacrificati per vestire i facoltosi, ma anche licheni dalla crescita lenta come la “Roccella tinctoria”. Il creatore di questo colore, William Perkins, fece la sua fortuna poiché iniziò subito ad essere di tendenza! Una sfumatura di viola è l’eliotropo, arbusto dal profumo molto dolce. Un antenato di questo fiore veniva infatti usato nell’antico Egitto come ingrediente per creare profumi. Oggi non è più un colore molto usato, ma continua ad avere un certo prestigio nella letteratura. Essendo infatti una parola piacevole da pronunciare, troviamo cenni di eliotropo nei libri di J.K. Rowling, James Joyce e Joseph Conrad.
Il blu dei nostri sogni
Joan Mirò definì il blu come il colore dei sogni. Tre quarti di secolo dopo si sarebbe scoperto che la sua affermazione non era poi così assurda: tutti i mammiferi, anche i non vedenti, hanno un recettore speciale che permette loro di recepire la luce blu. Oggi un sondaggio condotto su 10 paesi diversi sparsi su 4 continenti ha rilevato che il blu è il colore preferito delle persone. Molto particolare è il blu elettrico, molto presto associato all’elettricità. Questo colore però ci riporta inevitabilmente al 26 aprile 1986, la notte in cui i lavoratori della centrale nucleare di Černobyl sentirono il suono del più grande disastro compiuto dall’uomo nella storia. I racconti di quella notte parlano infatti di un fascio di luce blu elettrico nel cielo, causato dall’aria che si ionizza.
Verde come il veleno
Continuiamo il nostro viaggio camminando su immensi prati verdi. Questo colore infatti fa pensare a scenari bucolici e a partiti a favore dell’ambiente, di solito percepita come una tinta pacifica, indice di benessere economico e buon gusto. Quale migliore sfumatura di verde dell’assenzio? Genepì, anice, finocchio e maggiorana selvatica in combinazione tra loro, pestate e poi fatte macerare nell’alcol, una volta distillate permettevano di ottenere questo liquore, una minaccia verde che si aggirava sul finire dell’Ottocento in Europa terrorizzandone i cittadini. Veniva considerato principalmente medicinale, nel giro di poco tempo però la gente iniziò a perdere la testa per l’assenzio. Sarà proprio di questo che parla Charles Baudelaire nella poesia “Il veleno” presente ne “I fiori del male”?
M… come marrone o mummia?
Il marrone non è un vero e proprio colore: non è presente infatti nell’arcobaleno e per crearlo dobbiamo scurire o ingrigire i gialli, o alcuni rossi oppure mescolare i tre colori primari. Questo probabilmente ha contribuito al fatto che sia stato disprezzato dagli artisti medievali. La sua sfumatura che ci ha colpito di più si chiama “bruno di mummia“! L’etimologia deriva dal termine persiano “mum” o “mumiya” che indicava il bitume: l’analogia tra il termine e la mummia portò a pensare che il bitume fosse contenuto in quegli stessi corpi e che si dovessero utilizzare dunque le mummie, pestate e ridotte in pasta, per ottenerne un composto quasi miracoloso. Pare che Francesco I di Francia andasse sempre in giro con un piccolo borsello di mummia in polvere e rabarbaro.
Nero come la paura… del buio
Concludiamo il nostro viaggio colorato con il nero: ci sono pochi colori in perenne espansione e pronti a inghiottire tutto. Il nero è imprevedibile, è il colore dell’eleganza ma anche del lutto. E la paura, che colore ha? Sicuramente il buio è il tipo di nero che fa più paura di tutti. Per gli esseri umani probabilmente questa paura risale ai giorni prima della scoperta del fuoco, è universale e antica. Quando è buio diventiamo infatti acutamente consapevoli dei nostri limiti di specie, perché senza la vista ci sentiamo vulnerabili. Eppure, solo con l’oscurità possiamo vedere le stelle e per quanto possa essere buio sappiamo che prima o poi il sole sorgerà di nuovo.
Un ultimo consiglio
Se vi è piaciuto il nostro viaggio nella storia dei colori vi consigliamo di leggere altre curiosità su “Atlante sentimentale dei colori” di Kassia St Clair!